

Per ricevere la newsletter Kritik, inviare una e-mail (senza testo)



Nosferatu: dal cinema al fumetto |
Le Icone tra Sicilia e Grecia |
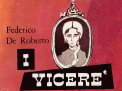
Recensione "I Vicerè" | Review "The Viceroys" |
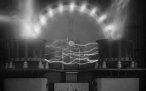
Il cinema nella Repubblica di Weimar |
 Nel Peloponneso. Viaggiando tra storia e leggenda. Memorie di un Filelleno
Nel Peloponneso. Viaggiando tra storia e leggenda. Memorie di un Filelleno Sicilia, valori e luoghi del design
Sicilia, valori e luoghi del design Roberto Radici
Roberto Radici ArteGenova 2026
ArteGenova 2026


 Oscar Piovosi
Oscar Piovosi Tycjan Knut
Tycjan Knut Giacomo Costa
Giacomo Costa Antonio Scordia. Un omaggio
Antonio Scordia. Un omaggio Cinque artisti per cinque materiali
Cinque artisti per cinque materiali William Kentridge
William Kentridge
 Valente Taddei
Valente Taddei

 Paragoni artistici: creatività senza confronto
Paragoni artistici: creatività senza confronto All'ombra simile o a un sogno
All'ombra simile o a un sogno


 Alfredo Romano
Alfredo Romano Toshimitsu Imaï
Toshimitsu Imaï Victoria Stoian
Victoria Stoian
 Omaggio a Francesco Ruberti
Omaggio a Francesco Ruberti Elisa Abela
Elisa Abela Autorotella
Autorotella Linosa: prosegue l'evoluzione del progetto Nereidee
Linosa: prosegue l'evoluzione del progetto Nereidee


 La scomparsa del Maestro Ernesto Piccolo
La scomparsa del Maestro Ernesto Piccolo "#000000"
"#000000"
 Zandomeneghi e Degas
Zandomeneghi e Degas Focus. 3 Artisti Israeliani.
Focus. 3 Artisti Israeliani. MAG2
MAG2 Mimmo Rotella. 1945-2005
Mimmo Rotella. 1945-2005
 Juliet 45 Years
Juliet 45 Years Fausto Pirandello. La magia del quotidiano
Fausto Pirandello. La magia del quotidiano Fotografia in Sinfonia
Fotografia in Sinfonia Achille Perilli
Achille Perilli Anna Caterina Masotti
Anna Caterina Masotti Gianfranco Zappettini
Gianfranco Zappettini Alfredo Casali
Alfredo Casali Silvia Muscolino
Silvia Muscolino Tothi Folisi
Tothi Folisi Visioni d'arte in Sicilia tra Ottocento e Novecento
Visioni d'arte in Sicilia tra Ottocento e Novecento Agnieszka Kurant
Agnieszka Kurant Giorgione
Giorgione Philippe Halsman
Philippe Halsman
 Antonio Scordia
Antonio Scordia Donazione Lokar
Donazione Lokar Plasmare l'Idea. Sculture e scultori oltre il XX secolo
Plasmare l'Idea. Sculture e scultori oltre il XX secolo "Vuoti abitati"
"Vuoti abitati" Gian Antonio Cibotto (1925-2017)
Gian Antonio Cibotto (1925-2017) Giorgio de Chirico
Giorgio de Chirico "carlaaccardi oroargento | dipinti 1964-1965"
"carlaaccardi oroargento | dipinti 1964-1965" Gastone Novelli (1925-1968)
Gastone Novelli (1925-1968) Emilio Vedova
Emilio Vedova Jerry Zeniuk. Il colore
Jerry Zeniuk. Il colore Terry Atkinson
Terry Atkinson Mario Nigro
Mario Nigro "Studio Crise"
"Studio Crise" Began with Rauschenberg
Began with Rauschenberg Giovanni Segantini
Giovanni Segantini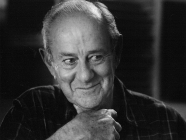 Walter Rosenblum
Walter Rosenblum Quantum Art. Oltre il visibile
Quantum Art. Oltre il visibile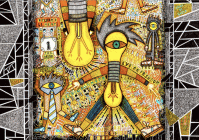 Stefano Chiassai
Stefano Chiassai MUNCH. La rivoluzione espressionista
MUNCH. La rivoluzione espressionista Leonor Fini e la collezione grafica Bassi Rathgeb
Leonor Fini e la collezione grafica Bassi Rathgeb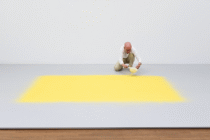 Wolfgang Laib
Wolfgang Laib Città. Voci e visioni
Città. Voci e visioni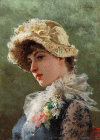 Accessori di classe
Accessori di classe Trieste, invenzione della mia anima
Trieste, invenzione della mia anima Archivio Caterina Gualco - Genova
Archivio Caterina Gualco - Genova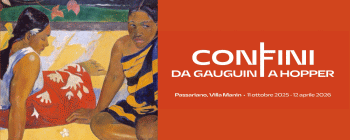 Confini da Gauguin a Hopper
Confini da Gauguin a Hopper Enrico David
Enrico David Nasce l'Archivio Regina
Nasce l'Archivio Regina Nasce in Italia l'archivio online dell'artista pre-pop americano Ray Johnson
Nasce in Italia l'archivio online dell'artista pre-pop americano Ray Johnson


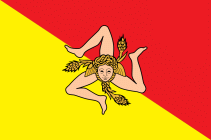 Potrà restare per sempre ad Atene il Fregio del Partenone proveniente dalla Sicilia
Potrà restare per sempre ad Atene il Fregio del Partenone proveniente dalla Sicilia
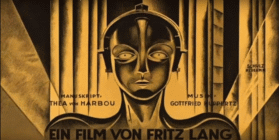 Archivi tematici del XX secolo
Archivi tematici del XX secolo Forme uniche della continuità nello spazio
Forme uniche della continuità nello spazio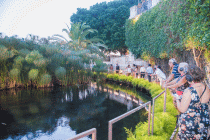


 ||| Sicilia ||| Apre al pubblico la Fonte Aretusa a Siracusa
||| Sicilia ||| Apre al pubblico la Fonte Aretusa a Siracusa Tracce di Parole. Anita Pittoni e Giani Stuparich a Trieste
Tracce di Parole. Anita Pittoni e Giani Stuparich a Trieste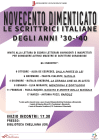 Novecento dimenticato: Le scrittrici italiane degli anni '30 - '40
Novecento dimenticato: Le scrittrici italiane degli anni '30 - '40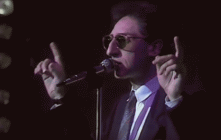 Franco Battiato
Franco Battiato Il diario di Angela. Noi due cineasti
Il diario di Angela. Noi due cineasti
 «In bocca al lupo»
«In bocca al lupo» I sei anni di Marcello Rumma (1965-1970)
I sei anni di Marcello Rumma (1965-1970) Marina Previtali, Milano messa in opera
Marina Previtali, Milano messa in opera "C'era una volta a Roma"
"C'era una volta a Roma" La vita dei dettagli
La vita dei dettagli Paul Russotto. Opere/Works 1956-2012
Paul Russotto. Opere/Works 1956-2012 "Nel Peloponneso. Viaggiando tra storia e leggenda. Memorie di un Filelleno"
"Nel Peloponneso. Viaggiando tra storia e leggenda. Memorie di un Filelleno"
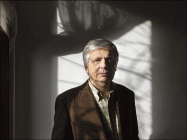 La materia del contendere
La materia del contendere I nascosti
I nascosti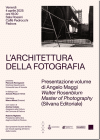 Walter Rosenblum. Master of photography
Walter Rosenblum. Master of photography Itinerari della rabbia
Itinerari della rabbia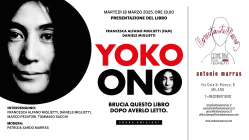 Yoko Ono. Brucia questo libro dopo averlo letto
Yoko Ono. Brucia questo libro dopo averlo letto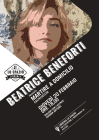 Martire a domicilio
Martire a domicilio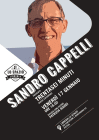 Trentasei Minuti
Trentasei Minuti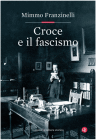 Croce e il fascismo
Croce e il fascismo
 Le parole risuonavano con incoraggiante semplicità
Le parole risuonavano con incoraggiante semplicità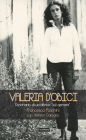 Valeria D'Obici
Valeria D'Obici

 Aldo Damioli
Aldo Damioli Cannoli Siciliani
Cannoli Siciliani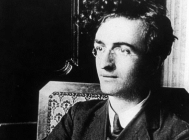 L'autobiografia della nazione
L'autobiografia della nazione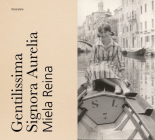 Gentilissima signora Aurelia
Gentilissima signora Aurelia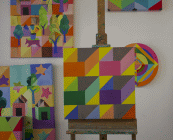
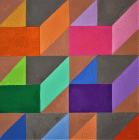 Poligoni platonici
Poligoni platonici
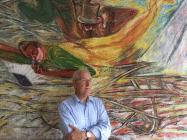
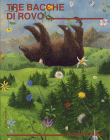 "Tre bacche di rovo"
"Tre bacche di rovo" Dopo Terra Matta
Dopo Terra Matta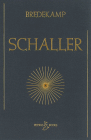 Matthias Schaller - Horst Bredekamp
Matthias Schaller - Horst Bredekamp Communism(s): A Cold War Album
Communism(s): A Cold War Album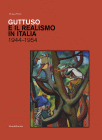 Guttuso e il realismo in Italia, 1944-1954
Guttuso e il realismo in Italia, 1944-1954 Eolie enoiche
Eolie enoiche 1989 Muro di Berlino, Europa
1989 Muro di Berlino, Europa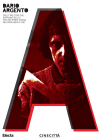 Dario Argento
Dario Argento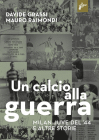 Un calcio alla guerra, Milan-Juve del '44 e altre storie
Un calcio alla guerra, Milan-Juve del '44 e altre storie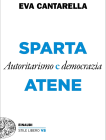 Sparta e Atene. Autoritarismo e Democrazia
Sparta e Atene. Autoritarismo e Democrazia Ultima frontiera
Ultima frontiera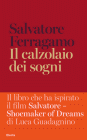 Il calzolaio dei sogni
Il calzolaio dei sogni Federico Patellani, Stromboli 1949
Federico Patellani, Stromboli 1949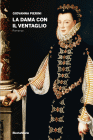 La Dama col ventaglio
La Dama col ventaglio Elogio della finta
Elogio della finta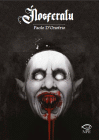
 Nosferatu
Nosferatu
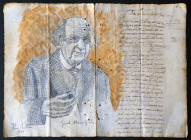 Errantia
Errantia L'ultima diva dice addio
L'ultima diva dice addio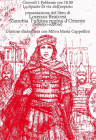 Zenobia l'ultima regina d'Oriente
Zenobia l'ultima regina d'Oriente Napoleone Colajanni tra partito municipale e nazionalizzazione della politica
Napoleone Colajanni tra partito municipale e nazionalizzazione della politica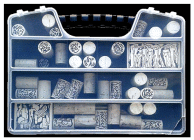
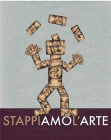 Stappiamolarte
Stappiamolarte
 Stelle in silenzio
Stelle in silenzio I quaranta giorni del Mussa Dagh
I quaranta giorni del Mussa Dagh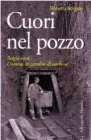 Cuori nel pozzo
Cuori nel pozzo La passione secondo Eva
La passione secondo Eva Odissea Viola. Aspettando Ulisse lo Scudetto
Odissea Viola. Aspettando Ulisse lo Scudetto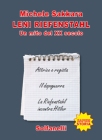 Leni Riefenstahl. Un mito del XX secolo
Leni Riefenstahl. Un mito del XX secolo Le stelle danzanti. Il romanzo dell'impresa fiumana
Le stelle danzanti. Il romanzo dell'impresa fiumana